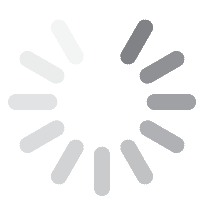Indice articoli

Un racconto ispirato da una storia di calcio femminile giovanile pubblicata su calciodonne.it ha dato vita a questo bel racconto che vi propongo in 4 puntate... buona lettura!
Non nego di aver provato forti emozioni a Parigi: quando vivevo in una mansarda di Montmartre, mi alzavo in anticipo per scoprire i primi bagliori del giorno, oltre i lucernari, sulle cime dei tetti di ardesia della periferia. Anche a Londra, quando abitavo nei pressi di Piccadilly Circus, la nebbia mi aggrediva e una passeggiata mattutina mi stupiva, facendomi credere di camminare su una nube carica di pioggia. Eppure a Roma le mattine d’inverno sono speciali, diverse dalle mattine di una qualunque altra città. Se il tempo è sereno, la città si specchia nell’azzurro intenso delle fontane e l’alba, che accorcia le ombre dei portici e dei monumenti, fa risplendere i colori della terra e del marmo. Roma si sveglia in una dimensione indefinita, sospesa tra presente e passato, la vista è così suggestiva che riesce a farti provare un po’ di calore anche nell’inverno più duro.
Probabilmente sono di parte nell’esprimere il mio giudizio, proprio perché di Roma ricorderò sempre questa storia e il modo in cui i sogni e il coraggio sono riusciti a riscaldare più di un cuore indurito dalle avversità della vita.
Tutto è iniziato nel mese di febbraio. L’inverno regalava giornate limpide e piene di sole, anche se restava perfidamente rigido, quasi aspettasse il momento giusto per tendere un’ imboscata. La giovane portiera, incinta di otto mesi, non sembrava mostrare particolare cura della sua condizione, lavava con ostinazione l’ampia terrazza, posta sulla sommità di una scalinata stretta e antica del palazzo che incrociava via Claudia con via Capo d’Africa.
Nemmeno lei sapeva con certezza cosa le fosse preso in una mattina così straboccante di luce; il freddo le pungeva sul petto, mozzando il fiato e lasciandole intorno nuvole bianche a ogni nuovo respiro. Sembrava profondamente rapita dallo scintillio di alcuni mattoni bagnati e dalla figura maestosa del Colosseo, riflessa sulla superficie del suo secchio d’acqua; lo rovesciava puntualmente sulle piastrelle annerite e, tra le lame di luce, lasciava che l’immagine specchiata si sciogliesse, scivolando in due o tre rivoli di sapone fino al canale di scolo. Ogni altra donna, essendo il tempo ormai prossimo, avrebbe evitato sforzi, ma lei né poteva permettersi di perdere il lavoro, né, per indole, avrebbe mai rinunciato a una mattina fiera e splendente come quella. Amava vedere la sua ombra arrotondata danzare tra il bastone e lo straccio. Le chiamava giornate di “ferro”, intendendo con un’unica parola il contrasto tra la durezza del gelo e la limpidezza del sole che l’accarezzava.
Sotto il cielo terso spiccavano i quattro pilastri dell’Arco di Costantino; riuscì a scorgere un’ultima volta, con la coda dell’occhio, il fregio del Sacrificio ad Ercole, sul medaglione di destra, mentre si accasciava sulle ginocchia, trattenendo l’urlo della prima fitta che l’aveva piegata dal dolore. Barbara e Sara, le sue gemelle, stavano arrivando in anticipo, e se era vero che il padre non le avrebbe mai conosciute, la madre, fin dal primo istante aveva lottato con la stessa fierezza di un eroe, per portarle al mondo prima e per proteggerle poi.
All’inizio gli amici avevano creduto che si trattasse di una gravidanza identica alle altre, poi, quando si erano resi conto che due vite avevano occupato lo spazio appena sufficiente per un neonato, si erano affrettati a darle per spacciate.
Nacquero deboli, premature, l’una abbracciata all’altra, col respiro così flebile che nemmeno i medici avrebbero scommesso sulla loro sopravvivenza. Prima dei sei mesi ebbero attacchi acuti di dissenteria e ogni sforzo per irrobustirle sembrava vano, anzi, ne derivò una perenne diffidenza nei confronti degli alimenti fondamentali come latte e acqua. Da quando iniziarono ad andare alle elementari, Sara assunse una carnagione sempre più pallida e perse quasi del tutto i capelli, invece Barbara, per nascondere un leggero strabismo, cominciò a girare con una benda da pirata sull’occhio sinistro. Alle medie in due non arrivavano a sessanta chili di peso, le chiamavano “gemelle malocchio” per quanto apparivano trascurate e lontane da una qualunque forma di bellezza. Ma, nonostante l’indifferenza degli altri, ogni sera prima di addormentarle la madre con amore e pazienza, dopo aver rimboccato le coperte, sussurrava loro all’orecchio quanto le amava, ripetendo sempre la frase: “Voi siete belle, voi siete speciali, voi siete importanti”.
A un certo punto, mentre continuavano a crescere, qualcosa avvenne. Sulla stessa terrazza dove erano venute al mondo scoprirono un gioco che le completava, le avvicinava, con cui iniziarono a prendersi una personale rivincita sul mondo: il calcio.
Il loro primo stadio non aveva erba, ma era fatto di mattonelle, sopra al palazzo di via Capo d’Africa, con la vista del Colosseo a fare da cornice. Giocavano qui fino al tramonto, rompendo le scarpe e continuando a correre a piedi nudi, una contro l’altra: una tirava, l’altra parava. La ringhiera faceva da fallo laterale e la povera madre aveva già fatto ritinteggiare a sue spese due volte il muro usato per la porta. Ma per lei fu un sollievo sapere che le sue ragazze non si sarebbero accontentate di mettere da parte i primi risparmi striminziti, inseguendo la moda in un centro benessere o sotto le lampade U.V. o, peggio, dentro una maschera di fango con due fette rotonde di cetrioli sugli occhi, senza mai sapere cosa significasse vincere o perdere. In fondo era stata proprio lei a ispirarle con storie di grandi calciatori, trasformate in favole per farle addormentare. Aveva raccontato le partite memorabili di Bruno Conti e Paolo Rossi del mondiale dell‘82, poi di quello vinto in Germania con Totti e Grosso nel 2006, segretamente sperando che la passione per lo sport facesse loro da padre, perché non avendone uno in carne e ossa, lo avrebbero trovato tra una finta o nella gioia di un gol segnato...
.... continua....
Mr. Onion (Diego Rossi)
Oltre al legame d’acciaio che si era instaurato tra madre e figlie, avvenne un fatto singolare: sul far della sera, quando il cielo sopra al Colosseo si tingeva di rosso e il sole assomigliava al nocciolo di una pesca, salì sulla terrazza Dino Zoff. Si dice che molti fatti strani alla fine definiscano il destino, così, essendosi trasferita una cugina del grande campione proprio nel palazzo delle due sorelle, Barbara e Sara furono viste giocare da Zoff, che si era accomodato sulla panchina, proprio sotto una fioriera invasa dall’edera. Le due sorelle erano talmente prese dalla sfida che nemmeno se ne erano accorte. A un certo punto spuntò dalle scale la mamma, brontolando qualcosa sulla cena, pronta da un pezzo, così, alzando gli occhi, le raggazze notarono finalmente chi stava seduto a pochi metri dalla palla. Dino Zoff non faceva mai lunghi discorsi, era in realtà salito in terrazza perché la cugina cominciava a lamentarsi di tutto quel trambusto, e lei gli aveva chiesto di usare un po’ del suo fascino per limitare l’energia delle due gemelle, che sembravano davvero due maschiacci. Zoff, anche se aveva superato i settant’anni, manteneva intatta la stessa sorpresa di quando, giovanissimo, con i compagni arrotolava vecchi giornali e con un elastico li trasformava in un pallone di carta, così, invece di rimproverarle si avvicinò e, dall’alto del suo metro e ottantadue, sotto le ciglia folte e lo sguardo serio, lasciò sfuggire un mezzo sorriso:
- Come vi chiamate?
- Sara, rispose all’istante l’attaccante, le parole le uscirono dalle labbra in un morso di entusiasmo.
- E tu, che sembri un pirata con quella fascia sull’occhio?
- Barbara signore, lui le accarezzava la testa e lei, per guardarlo meglio si alzò la benda, il leggero difetto non sminuì i suoi occhi grandi di bambina, puri e sinceri.
- Parare è una vocazione e un sacrificio, continuò Zoff, e tu hai già la geometria giusta… volevo chiedervi di smettere, ma mi avete davvero sorpreso, uno contro uno ricordate la parte più bella del calcio.
Mentre la mamma si affrettava a scusarsi, ammettendo che non era opportuno fare tanto rumore sulla terrazza, non era il posto più adatto per grida e schiamazzi, Sara si affrettò a chiedere:
- Vorremmo vincere qualcosa signor Zoff, ce la faremo un giorno?
Allora lui, prima di andarsene, ci tenne a precisare:
- Vincere è anche questione di fortuna, bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Ho pensato molte volte a Giovanni Galli, che nel mondiale del 1986 mi sostituì, alle sue mille disavventure e al suo cuore grande, capace di sopportarle . Ripenso al gol fantastico di Maradona, al sole così alto quell’anno, era allo zenith e lasciava solo lo spazio di un’ombra minuscola, sfuggiva, si nascondeva sotto gli scarpini. Ci penso spesso e mi chiedo, dopo tutto quello che ho vinto, avrei parato il gol all’Inghilterra? Avrei sopportato un caldo così asfissiante? Quanto conta il destino e quanto il talento invece? Ma questi sono solo discorsi da vecchio, non sono adatti a due ragazzine che si divertono a giocare. Ogni posto è giusto per sognare, dietro una chiesa o su un terrazzo si vincono i mondiali più importanti.
Così le due sorelle videro Zoff scendere le scale strette che la mamma lavava ogni due giorni; salì sulla sua smart grigia e a loro quasi prese un colpo per la gioia di un momento che non avrebbero mai più dimenticato.
C’erano però due fratelli, più o meno della stessa età di Barbara e Sara, il più grande aveva un anno in più, il più piccolo un anno in meno, giocavano a calcio, frequentavano la stessa scuola e abitavano nello stesso palazzo, loro però erano ricchi e maschi; per gli allenamenti uscivano dal palazzo verso le quattro del pomeriggio, tre volte la settimana, vestiti con una divisa azzurra lucente, con gli scarpini chiodati già ai piedi. Aspettavano che il padre li raggiungesse nell’androne, qui davano un saluto distratto alla portiera, ma solo se costretti. Se invece nel gabbiotto c’erano le due gemelle che disegnavano o facevano i compiti, con l’aria strafottente dei grandi campioni le deridevano, rinfacciandogli che il calcio era cosa da uomini e non da donne. Si erano meritati un soprannome pittoresco, in fondo erano stati proprio loro a battezzare le due ragazze: gemelle malocchio. Per tutti erano noti come “gli scimmioni”. Portavano capelli ricci e folti, questi ultimi avevano preteso la licenza di crescere ovunque sui loro corpi, lasciando libera soltanto la fronte smisurata e i nasi adunchi. Il più grande aveva già la barba a quasi quattordici anni, il più piccolo aveva piedi enormi; entrambi indossavano pantaloni corti allacciati dalla corda della divisa alla vita, ne uscivano fuori gambe muscolose, ricoperte di lanugine aggrovigliata che conferiva loro un vero e proprio aspetto scimmiesco. Per povertà di spirito o per il tipo di presunzione che, a volte, una vita troppo agiata trasmette, credevano che la terra di un campo sportivo in qualche modo gli appartenesse.
Mentre gli scimmioni battevano calci d’angolo dalla lunetta e facevano scatti sull’erba sintetica del loro centro sportivo, per un ragazzino meno fortunato giocare a calcio voleva dire fare i cosiddetti dribbling di strada, cioè significava correre in piazza ed essere comunque immensamente felice, ma per le gemelle malocchio era anche qualcosa di più, voleva dire vincere, vincere sul campo e nella vita, dimostrando che si è forti più della sfortuna, più di un ragazzo. Così le gemelle, senza particolari forme da mostrare, dentro tute rattoppate e con la pelle nera come la sera per la polvere raccolta a furia di scivolate e cadute, coi capelli tagliati alla militare, erano diventate abbastanza forti per allontanarsi dalla loro terrazza e iniziare a confondersi coi maschi, passando alle piazze e ai campetti di fango. Soprattutto prima di cena, sotto i lampioni, mettevano alla prova i loro progressi evitando a zig zag buche e tombini. Le porte erano delimitate da giacche, zaini o quello che capitava. Per vincere erano disposte a tutto, ma solo su una cosa apparivano irremovibili: Barbara e Sara avevano e avrebbero sempre giocato insieme, come se nella squadra in cui capitavano ne esistesse sempre un’altra più piccola, più importante di ogni altra cosa al mondo. Iniziarono ad amare le strade bagnate dalle bolle di luce arancione dei lampioni.
Verso le sei e mezza del pomeriggio, col cappuccio di una felpa tirato sugli occhi riuscivano a non farsi riconoscere, nascondendo ai ragazzi che erano donne, perché altrimenti le avrebbero escluse. Non parlavano molto, giocavano e basta. Intanto sognavano che i mattoni larghi che avevano sotto i piedi un giorno sarebbero diventati il prato verde dell’Olimpico e dalle giacche o dai sassi sarebbero poi spuntati pali lisci e bianchi.
Però una domenica pomeriggio tornarono a casa ed erano inconsolabilmente tristi...
era accaduto quello che temevano di più; non era la tristezza per una partita persa, era la tristezza di essere state smascherate, proprio nel momento più bello che avevano mai vissuto. Alle 11.00 di mattina in punto avevano raggiunto, come molte volte prima, Villa Pamphilj. Qui tutti i ragazzi si ritrovavano per una sfida avvincente. Ai margini del percorso dedicato ad Abebe Bikila, il grande maratoneta che vinse a piedi nudi le olimpiadi di Roma ’60, su una vasta zona verde delimitata da platani e pini libanesi, ci si scontrava per conquistarsi il diritto di gioco. I vari campi erano più che altro immaginari, non c’erano linee o delimitazioni chiare, e per questo apparivano ancora più affascinanti, perché ognuno ci fantasticava sopra. Uno era il Bernabéu, un altro il Camp Nou e così via, ma in un ordine ben noto ai partecipanti, i vari rettangoli verdi erano assegnati in base alla forza dimostrata sul campo. La squadra di ragazzi e delle gemelle malocchio era composta da otto tredicenni affamati di sport e di avventura. Per la prima volta era riuscita ad avere la meglio su attempati giocatori di età indefinite, abili e assidui frequentatori del parco. Tutti avevano praticato campi sportivi e, fino a quella mattina, avevano difeso il primato di squadra imbattibile. Un nugolo di spettatori si era assiepato ai margini del campo principale, alla fine della salita che sovrasta il lago e si trova alle spalle del giardino principale della villa, volevano assistere a questa sfida preliminare, che durava di solito una ventina di minuti e terminava col primo gol segnato. Vedere dei ragazzini muoversi in modo così agile tra le gambe di uomini più forti ed esperti era davvero un grande spettacolo. La gioia immensa per un’impresa memorabile durò troppo poco però. Addirittura c’era il selezionatore di un famoso circolo sportivo tra i perdenti, che stava facendo i complimenti alla squadra delle gemelle; raccontava di Davids e Zidane, due grandi campioni che amavano confondersi con i ragazzi di strada, indossando occhiali scuri per non farsi riconoscere e per gustare l’emozione sincera di una partita più vera di quella giocata in uno stadio. Anche Barbara e Sara, pensando al loro segreto, si erano sentite elettrizzate dalle sue parole, ma il circolo sportivo del selezionatore era lo stesso degli scimmioni, lì presenti, confusi tra il pubblico. Passarono pochi istanti perché, questi ultimi, riconoscendole non sputassero in faccia al mondo intero la verità. Bastò il grido: “Sono solo due ragazzine quelle, così brutte che fanno finta di essere maschi, sono le gemelle malocchio!”, e tutto cambiò.
Dopo un istante di assoluto silenzio, dopo aver visto il buco nella folla che si era aperto intorno a loro, percepirono lo stupore mutare in sdegno negli stessi giovani compagni di molti pomeriggi di sport. Un alito di vento lasciò frusciare di invidia l’erba del prato, e accompagnò la corsa veloce e rabbiosa di Barbara e Sara tra la pioggia di risate e frasi poco lusinghiere sulle donne calciatrici; cercarono di non sentire, correndo più forte tra i pini ai bordi del viale verso l’uscita di via Vitellia. Cercavano di rammentare la prima volta che avevano sgonfiato un pallone per calciarlo con maggiore velocità. A mente ripetevano la frase che ogni sera la mamma dedicava loro: “Voi siete belle, voi siete speciali, voi siete importanti”, ma le lacrime non smettevano di scendere, si vedevano solo come due bambine spavalde, ma a cui la strada aveva insegnato a piangere.
Passarono due settimane, la portiera aveva la busta in mano, con dentro la lettera che non sapeva più se imbucare o meno. Ripensava alla cattiveria dei fratelli scimmioni, erano ancora troppo ingenui in fondo, però avevano strappato alle figlie la gioia di entrare a far parte di una squadra vera; lei non possedeva seicento euro per iscriverle a una scuola calcio, per offrire loro qualcosa di meglio. Una volta Sara era tornata a casa così spaventata perché a furia di provare punizioni aveva rotto il finestrino di una macchina e, per la vergogna, si era mangiata le unghie fino a farle diventare rosse di sangue. La busta scivolò dentro la cassetta rossa. Si udì un colpo violento, per un istante la portiera si spaventò, fantasticando sui sogni che si infrangono portò la mano sul petto, ma poi si accorse che era mezzogiorno e, il frastuono del cannone del Gianicolo riecheggiava in lontananza, infilandosi dentro le sue preghiere.
Gentile signor Zoff,
pensavo alle mie figlie, ai loro dribbling di strada e alla tristezza di un compleanno passato in casa a guardare la televisione, nonostante il sole fosse alto e, come sempre, così invitante sulla nostra terrazza; provo allora a scrivere questa lettera, rammento la volta che ci ha conosciuto, ripenso al suo sguardo ammirato, ai suoi suggerimenti sul gioco e a tutto quello che è successo dopo. Perché le mie ragazze non saranno mai brave come i ragazzi. Tutti pensano questo, anzi, ne sono certi!
Provo allora a chiederle aiuto, e vorrei farmi forza con l’immagine di un film straordinario: Million Dollar Baby. Vorrei che Barbara e Sara avessero un’occasione, magari per diventare come la Margaret del film. Lei si sentiva fuori posto, sola, proprio nel giorno del suo compleanno, alla fine di una serata passata in palestra, ma col sorriso di un angelo caduto nell’inferno degli uomini della boxe. Senza grazia, senza coordinazione, stringeva i pugni e tirava cazzotti al destino. Le lacrime scendevano invisibili, sotto la pelle, nella consapevolezza di non avere altri sogni da inseguire se non attraverso uno sport fatto di sfida, affermazione, rabbia. Le stesse lacrime, sono convinta, scorrono anche sulle guance delle mie due ragazze, che combattono contro l’indifferenza di molti uomini nel calcio. Margaret sapeva che non sarebbe finita al tappeto senza combattere: voleva la sua possibilità. A un certo punto nel film arrivano le parole di questa scena, che mi danno una speranza e completano il quadro. Il signor Dunn (Clint Eastwood) si avvicina alla pugile che continua ad allenarsi, nonostante lui avesse sempre rifiutato di seguirla, proprio perché donna e avesse continuato a ripetere a se stesso tutti i giorni: “che diavolo poteva capire una donna di pugilato?”. Eppure lì, davanti ai suoi occhi coglie per la prima volta l’essenza di un animale ferito. La vede ostinata, ignorata o derisa, capisce che per lei non conta il giudizio degli altri, le basta stringere i denti e tirare pugni, quasi fosse un modo di riflettere, di brandire una spada, di essere più valorosa, più appassionata, più viva. Ecco il dialogo più toccante. L’allenatore si avvicina e le chiede:
- Così è il tuo compleanno, quanti anni compi?
- Compio trentadue anni signor Dunn e festeggio il fatto che ho passato l’ennesimo anno a lavare i piatti e a fare la cameriera. Cosa che faccio da quando ho compiuto tredici anni e, secondo lei, dovrò compierne trentasette prima di diventare un pugile decente. E dato che è un mese che tiro pugni a questo sacco veloce senza risultati; comincio a rendermi conto della verità. L’altra verità è che mio fratello sta in galera, mia sorella truffa la previdenza sociale, fingendo che suo figlio sia ancora vivo, mio padre è morto e mia madre pesa oltre centoquaranta chili e, se dovessi ragionare a mente fredda, dovrei tornare a casa, trovare una roulotte usata, comprare una friggitrice e dei biscotti. Il problema è che mi sento bene soltanto quando mi alleno. Se sono troppo vecchia, allora non mi resta niente. Le basta come spiegazione?
- […] Ti farò vedere un paio di trucchetti e, poi, ti cercheremo un allenatore.
- No. Lasci stare.
- Vuoi anche dettare tu le condizioni?
- Sì signore! Perché so che se sarà lei ad allenarmi diventerò una campionessa. L’ho visto come mi guarda.
- Sì. Con pietà…
- No. Non mi dica così. Non deve dirmi così se non è la verità. Io voglio un allenatore, non voglio l’elemosina e non voglio che mi faccia favori. E se non è interessato, vorrei continuare a festeggiare.
Il signor Dunn non aveva potuto che iniziare ad allenare il miglior pugile che avesse mai incontrato.
So che è solo un film, ma è anche la speranza a cui mi aggrappo con questa lettera, che magari lei possa aiutarle.
Si presentò con un sorriso largo, aveva pochi capelli, ma la sicurezza di non nasconderli sotto un cappello; gli occhi limpidi, la stretta di mano decisa e i palmi pieni di calli mostravano dita abituate a fare più che a parlare. La guardò e disse:
- Albino Pizzaballa, piacere, lei sarebbe?
Il suo nome le ricordava qualcosa, ma sul momento rispose soltanto:
- Irene Ferragatti, la portiera.
Poi ci pensò, fu un lampo:
- Mi scusi, c’entra qualcosa quel Pizzaballa?
Pizzaballa era la famosa figurina dell’album Panini del ‘63-64. Il grande giocatore era effettivamente un suo parente e non aveva fatto la foto di rito perché influenzato, né a quei tempi fare una foto era cosa da poco. Per questo l’album del campionato di serie A di quella stagione mancava di una figurina che era diventata “leggendaria”, la figurina più ambita tra il popolo di giovani ragazzi appassionati, che amavano lo sport all’aria aperta e non conoscevano ancora le play station dell’epoca dei computer, ma con la fantasia erano comunque capaci di viaggi altrettanto straordinari.
Albino, entrato ormai in confidenza, finalmente rivelò il motivo per cui era venuto:
- Sto mettendo su una squadra femminile per farla partecipare al campionato di esordienti regionale… - dopo un colpo di tosse precisò - …”maschile”.
Irene quasi svenne, ma tenne duro. Non faceva che ripensare alla lettera che aveva scritto, al destino e alla frase catturata in un libro che continuava a vegliare su Barbara e Sara: “Voi siete belle, voi siete speciali, voi siete importanti”.
- Sono qui per le sue figlie… - continuò lui - …un amico comune mi ha detto che fisicamente sono davvero gracili, ma che hanno la grinta di cui la nostra squadra ha più bisogno; perché vogliono far vedere che sono migliori di un ragazzo!
Irene nella piccola casa dove era nata aveva imparato che troppe volte i vestiti buoni si mettevano da parte in un armadio, aspettando invano un giorno che non sarebbe poi mai arrivato. Aver conosciuto Albino le aveva lasciato addosso la stessa sensazione strana e che non provava da tanto tempo. Avrebbe voluto avere ai piedi scarpe meno consumate, qualche goccia del profumo che centellinava nel bagno. Con le dita si accarezzava i capelli appena mossi, erano di un tenue colore castano chiaro, sperava di apparire più carina di quanto si sentisse.
Il tempo volò, i sogni li aspetti una vita e se si realizzano succede tutto in un lampo. Un allenatore abbastanza matto aveva iscritto una squadra femminile ad un campionato maschile. Domenica dopo domenica questa si era conquistata il secondo posto e proprio in finale, a quindici minuti dalla fine dell’ultima partita, incontrando la squadra dei fratelli scimmioni, se avesse segnato un gol, in un colpo solo l’avrebbe scavalcata e vinto il campionato.
Sara si era trovata una quindicina di metri indietro rispetto alla sua posizione abituale, correva a centro campo, scartò un avversario con semplicità, fece una finta e aveva il pallone davanti, poteva passarlo facilmente, ma qualcosa le brillò negli occhi. Barbara, poche azioni prima, aveva evitato un gol fatto, lanciandosi in aria all’indietro e, ricadendo sulla linea di porta, si era rigirata come fanno i gatti quando cadono a terra e recuperano la posizione corretta. Aveva dato però un colpo violento col ventre sull’erba, rimanendo con la guancia sul pallone che avvinghiava stretto tra i guantoni. Sara era corsa per vedere se andava tutto bene e la sorella le aveva solo lanciato un segnale rassicurante, intendeva che sarebbe arrivato il momento, che, in qualche modo e per qualche oscura ragione, la palla che aveva salvato dalla porta ora sarebbe passata a lei, e tra i suoi piedi lei avrebbe capito il momento giusto per valorizzarla, allora le bisbigliò soltanto: “ora custodiscila tu”.
Sara sentì che il momento era arrivato. Non ascoltò i rimproveri di Pizzaballa, si era alzato dalla panchina e voleva che la passasse, ma lei fissò il più grande degli scimmioni, era lì, pochi metri davanti e cercava di intimidirla con un ghigno cattivo: le tese contro la gamba e provò a farle male, ma successe come mille volte era successo nei sogni. Lei, fintando di accentrarsi, di colpo si era voltata e col tacco aveva guadagnato lo spazio sulla fascia sinistra. Albino Pizzaballa non si trattenne, cominciò a correrle al fianco, lungo la parte esterna della linea del fallo laterale, avrebbe voluto gridare: “passa la palla, passala dannazione”, ma la vide saltare un ultimo avversario ed era ormai vicina alla porta; allora si fermò, trattenne il fiato per un istante e poi saltò con le braccia alzate: la palla era entrata, era gol, “uno a zero!”, gridò, quando mancavano tre minuti alla fine. Sembrò che il tempo si fosse fermato per il silenzio che aveva invaso il campo. Avvenne proprio a Roma e per la prima volta: una squadra di donne aveva vinto il campionato giovanile maschile .
Se questa storia fosse un film riavvolgerei il nastro, rivivendo scena per scena come se fosse la prima volta, ma non si può ed è un’immensa tristezza. Resta il ricordo di una città unica con l’ aria pigra di un sabato pomeriggio di fine primavera, vasto e misterioso, in cui grida di vittoria e urla di felicità si perdevano in fretta, lasciandosi dietro solo il fantasma di un’eco. Ho provato a descrivere le mie emozioni in poche pagine. Sono il cronista di un quotidiano sportivo e questa è la sensazione che provo dietro la tastiera adesso, battendo l’ultimo giro di pensieri: nella vita lasci le cose che fai, a volte sono come disegni sulla sabbia, possono essere spazzati velocemente da un po’ di vento o dalle onde del mare, ma alcune storie sono speciali, a furia di ripeterle e raccontarle fanno strani giri e rinascono intatte, custodite da un nuovo cuore che le porterà con sé. Ecco cosa mi è capitato di vedere a Roma di tanto unico e che non dimenticherò mai! Non erano solo ragazze che inseguivano un pallone, ma vedevo anche il loro sogno diventare realtà. La loro mamma continuava a pensare a questo pomeriggio perfetto, quando si ritrovava col secchio in mano e dentro vi scorgeva l’immagine riflessa del Colosseo; passando lo straccio sui mattoni rossi riconosceva le minuscole crepe delle prime cadute sulle ginocchia di Barbara e Sara, sospirava spazzando la polvere leggera che aveva reso i capelli delle figlie più simili alla paglia che a quelli di due principesse delle favole. Eppure adesso la loro favola la inseguono in una scuola calcio a Milano. Così Irene ride, le mancano certo, ma ricorderà sempre la finale, la loro più grande partita. Poi scende per la scala stretta, dove l’ombra fa morire il giorno e proprio lì si ferma un attimo, un leggero baffo di umidità disegna i colori dell’arcobaleno. Non trattiene una lacrima, ricordando i giorni in cui era solo lei a credere in loro e ora, invece, tutto il mondo sa quanto “sono belle, speciali, importanti”.
***
Mr. Onion, Diego Rossi, gennaio 2016.